Alcune pagine dello splendido libro "In Siberia" dello scrittore di viaggi Colin Thubron che raccontano la realtà e il passato del "pianeta" Kolyma.
[In viaggio da Jakutsk verso Magadan e la Kolyma] Gli unici altri passeggeri sul mio bimotore Antonov erano tre soldati intabarrati nei cappotti e coi berretti calcati sulle orecchie per proteggersi dal freddo. Sotto di noi scorreva la Lena, gelata da riva a riva, con ancora qualche rivoletto grigio acciaio che serpeggiava tra il ghiaccio.
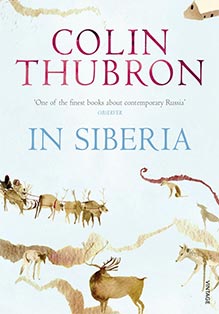
Ma tutti gli affluenti erano compatti e i banchi di ghiaccio trascinati dalle correnti si erano arenati sugli isolotti coperti di neve. Avevo sperato di trovare un camion diretto a est, verso Magadan e il Pacifico, ma l’unica strada era inagibile, crepata dal permafrost, e l’Antonov malconcio era stato l’unico mezzo disponibile. Quando decollò sopra Jakutsk, la città mi apparve un collage disarticolato di migliaia e migliaia di casette sprofondate nella neve, con i muri che sembravano tratteggi a matita e i sentieri scuri intorno. Mi parve di intravedere lo spazio vuoto del circo di Marfa e Sergej, poi riconobbi la statua miniaturizzata di Lenin nella piazza, infine la scacchiera dei condomini dove Tanja aspettava il futuro e dove Mochanov si arrovellava sull’origine dell’uomo. Alla fine le nuvole coprirono tutto e puntammo a est, sotto un cielo sempre più scuro.
Le vibrazioni leggere e continue dell’aereo mi tennero sveglio, in un vago stato di allerta. Di tanto in tanto, quando le nuvole si squarciavano, un deserto ghiacciato di monti baluginava sotto di noi, senza segni di vita. Una desolazione selvaggia che andò avanti per mille chilometri. Settecento anni prima, lungo l’unico sentiero tracciato, uno sparuto gruppo di commercianti di Jakutsk portava alle tribù impoverite mattonelle di tè e vodka di contrabbando, per ritornarne con avorio di mammut, pellicce e qualche ragazza destinata ai bordelli di Jakutsk, venduta dai clan al prezzo di una misera renna. Adesso sotto di noi le valli erano annerite da lanci stentati, e i fiumi giacevano inerti. Poco dopo sorvolammo un ghiacciaio vergine punteggiato di picchi e burroni. La sua glaciale immobilità riempì la cabina. I soldati dormivano imbacuccati e io guardavo giù, inebetito. Nella memoria dell’uomo contemporaneo, quella vastità era solo un continente di campi di sterminio.
Nel 1931, qualche anno dopo la scoperta di immensi giacimenti auriferi, una regione che abbracciava tutta la Siberia nordorientale oltre il fiume Lena — un territorio più vasto del Messico — fu messa sotto il controllo di un’agenzia che si chiamava Dal’stroj e che divenne ben presto una branca del ministero degli Interni e della polizia. Dal’stroj era una legge a parte. Sotto la sua giurisdizione la costituzione sovietica non entrava in vigore. Governò un incubo a occhi aperti. Questa terra della Kolyma ricevette in dono ogni anno decine di migliaia di prigionieri arrivati via mare, la gran parte innocente. Nel punto in cui sbarcarono costruirono il porto, poi la città di Magadan, poi la strada verso l’interno fino alle miniere, dove morirono.
All’inizio i detenuti erano kulaki e criminali comuni, poi — quando la paranoia di Stalin dilagò — presunti sabotatori e controrivoluzionari di ogni classe: funzionari di partito, soldati, scienziati, medici, insegnanti, artisti. Perirono nelle gallerie delle miniere, uccisi dai crolli o dai carichi, dai fumi di ammonio e dalla silicosi, dallo scorbuto e dalla pressione del sangue troppo alta, sputando sangue e tessuti polmonari. In inverno, quando le caldaie a vapore fondevano la sabbia aurifera, trascinavano le scorie dai capanni per il trattamento di separazione all’esterno, dove la temperatura scendeva sotto i quaranta gradi, ed entro un mese morivano di polmonite o di meningite.
Dopo meno di dieci anni la Kolyma arrivò a fornire un terzo della produzione mondiale di oro. Ogni chilo,è stato calcolato, costò una vita umana. Ma il numero dei morti rimane di fatto sconosciuto. Si è ipotizzata una cifra oltre i due milioni. Era già notte quando atterrammo a ottanta chilometri dal Pacifico, a Sokol [Sokol-Magadan nella Kolyma], dove dormii in una pensione vuota. Due corriere a lunga percorrenza, mi dissero, viaggiavano ancora all’interno quando le nevicate non erano troppo forti, e fu con una di quelle — e con un po’ di autostop — che mi inoltrai fino alle colline della Kolyma.
Avevano la monotonia dell’eternità. Contornavano la strada come echi o riflessi di se stesse, arrotondate come antichi tumuli. In qualche caso il vento aveva eroso le cime riducendole a pelate di roccia marrone. Sembrava un territorio informe, trascinato in qualche altra era geologica. E illuminato solo per metà: il sole infatti saliva percorrendo un quarto del cielo ma poi subito ridiscendeva. La strada che percorsi superando villaggi silenziosi collegava un tempo Magadan con un arcipelago di campi auriferi, lungo un tratto di cinquecento chilometri. Ancora oggi viene chiamata la «Strada delle Ossa». All’inizio furono migliaia i prigionieri impiegati nella sua costruzione, ma era sempre invasa dal fango e il gelo distruggeva il lavoro fatto. Ci vollero ottantamila travi di legno per il consolidamento di un solo chilometro. L’arrivo delle prime nevicate nel 1932 colse i detenuti ancora alloggiati nelle tende e in capanne improvvisate con sterpaglie. Fu uno degli inverni più crudeli a memoria d’uomo. Le tormente di neve infuriarono senza sosta per settimane. Interi accampamenti perirono sotto il gelo: prigionieri, guardie, persino i cani. Di migliaia di lavoratori, solo uno su cento fece ritorno a Magadan la primavera successiva. I primi dirigenti del Dal’stroj furono fucilati come spie nel 1937. Da allora si instaurò un regime di pura crudeltà. Gli indumenti di pelliccia e gli stivali dei prigionieri vennero sostituiti con calzature di tela e giacche imbottite, che si ridussero ben presto a brandelli.
L’intenzione era quella di uccidere. Si passò a una dieta da fame: ottocento grammi di pane, con l’aggiunta saltuaria di qualche pezzetto di pesce salato o di cavolo in salamoia. I deportati si ridussero a mangiare le carcasse degli animali, i licheni buoni per le renne, il grasso delle carriole. La giornata lavorativa raggiunse le quattordici ore, le condanne da scontare i venticinque anni. Si promisero riduzioni di pena a chi avesse raggiunto quote di produzione in realtà irraggiungibili. Le squadre lavoravano freneticamente, ma i corpi logorati dalla fame non reggevano lo sforzo. Se la capacità produttiva si riduceva, per punizione venivano ridotte le razioni alimentati, e la squadra entrava in una spirale di declino fatale. Ogni sera e ogni mattina gli ufficiali, levando la brina dai fogli che tenevano in mano, leggevano elenchi dei condannati a morte e di quelli già giustiziati, e dopo il discorso la banda musicale dei detenuti suonava una piccola fanfara. In tre settimane le miniere rovinavano la salute di un uomo, e in pochi mesi lo uccidevano. A volte intere squadre venivano prelevate sul lavoro e fucilate all’istante. I criminali comuni venivano scelti come sorveglianti e armati di bastoni, e potevano assassinare i detenuti politici impunemente. (il sistema di eliminazione consueto consisteva nel sollevare un uomo e buttarlo a terra fino a che le ossa, già decalcificate, si spezzavano). La maggior parte, però, scivolava nella morte senza che la cosa fosse neppure notata.
Alcuni dei comandanti facevano quel lavoro con gusto, arrivando a scaricare le pistole sui lavoratori schierati durante la rassegna con grida di giubilo. In alcuni campi non ci fu neanche un superstite. In posti così si perdono i propri occhi, e si comincia a vedere attraverso quelli di chi li è morto. Non si ha diritto a quel luogo. E un luogo che appartiene a loro. Ci sarà anche qualcosa di bello? Non si sa. Si vedono solo cartelli stradali che indicano località atroci: Sturmovoj, Urchan, Ojmjakon. I campi lungo la strada sono stati saccheggiati del poco materiale utilizzabile. Solo qualche baracca viene riutilizzata come deposito, altre sono ridotte in macerie, circondate da qualche superstite picchetto di cemento. Le torrette di sorveglianza sono crollate. Tumuli e trincee si confondono sotto la neve e tra gli sterpi incolori. Nella notte la corriera raggiunge gli edifici illuminati a giorno di Orotukuan: sessanta anni prima era un centro per interrogatori interminabili, disseminato dei cadaveri di chi aveva dovuto attendere troppo a lungo. Adesso una ragazza vende succhi di frutta da un chiosco senza luce. A sessanta chilometri da li, una valle laterale conduce a Elgen, il campo femminile dove Evgenija Ginzburg [si veda anche Il trasferimento in mare per Kolyma], accolta da un’orda di automi dalle facce paonazze, entrò piangendo all’idea di quello che sarebbe diventata. Perfino i sorveglianti disdegnavano di stuprare quelle donne. A Jagodnoe incappai in un gioviale quartetto di mafiosi che mi portò in giro per la città su una jeep Nissan. « Inglese? Veramente? Come mai qui? Qui è una merda. E venuto per affari? E allora perché, perché? »
Era passata mezzanotte e giravano in cerca di prostitute, ma la città sembrava morta. Mi trovarono un letto in un dormitorio, pagarono loro il portiere: «Dono dei russi! » e scomparvero nella notte. Mi svegliai in un alba gelida, con le montagne splendenti sotto un cielo di porcellana. Sì, era dolorosamente bello. Nella città semivuota il mio arrivo non era passato inosservato: nessuno sano di mente veniva a Jagodnoe senza un valido motivo. Due giornalisti locali mi condussero più a sud lungo il fiume locale, fino a Serpentinka. La strada era lastricata di ghiaccio e gli affluenti della Kolyma intorbidati da vecchi mucchi di materiale di scarto che li seguivano simili a detriti di talpa. I tumuli più imponenti delle montagne sembravano repliche stagliate contro il cielo. Le rive ospitavano draghe abbandonate. I deportati erano scomparsi da quarant’anni e i cercatori d’oro avevano preso il loro posto. Ma negli ultimi anni più della metà se n’era andata alla spicciolata, mi dissero i giornalisti. Qua e là,’ dalla strada appariva qualche insediamento sventrato, insieme allo scheletro di una fabbrica o di una fornace di mattoni. Su uno sperone sopra la strada che scendeva serpeggiando fino al fiume ci accolse Serpentinka.
Pavlov e Garanin, i nuovi signori del Dal’stroj, ne avevano fatto un centro di tortura e sterminio. Era il cuore nero della Kolyma. Su uno strapiombo vicino alle celle d’isolamento, due trattori venivano tenuti con i motori al massimo per soffocare gli spari e le grida delle esecuzioni. Nel 1938 vi morirono ventiseimila prigionieri, centinaia per mano dello stesso Garanin. I corpi venivano trascinati dietro la collina su slitte trainate dai trattori, oppure i prigionieri venivano condoni ancora vivi e a occhi bendati sull’orlo delle fosse e uccisi con un colpo di fucile alla testa. Poi, in linea con la politica di Stalin di liquidare i responsabili degli apparati di sicurezza, anche Garanin fu fucilato, e con lui tutto il personale di Serpentinka, e il campo venne raso al suolo. Vagammo in quella vacua vastità accompagnati dallo scricchiolio della neve sotto i piedi. Nel silenzio perfino le voci erano troppo rumorose. Un blocco di granito circondato da filo spinato e fiori di plastica era stato posato in memoria delle « decine di migliaia » assassinate dallo Stato. Luccicava sotto un manto di ghiaccio. Poco oltre, tra mucchi di neve e cespugli moribondi, un sentiero spettrale andava a perdersi nel nulla.
Guardi attorno con gli occhi dei morti, e non vedi speranza. Nessuno è sfuggito. Chiamavano Kolyma «il pianeta», privato di qualsiasi futuro, al di fuori di qualsiasi realtà. Nel tentativo disperato di rifugiarsi all’ospedale, i prigionieri si iniettavano kerosene sotto la pelle, si strofinavano l’acido sulle palpebre, si mozzavano le dita, simulavano la follia. Ma a poco a poco si riducevano a selvaggi, affamati e umiliati. Diventavano gli anima l in cui le autorità avevano deciso di trasformarli, così la loro morte non lasciava la coscienza sporca. Si univano agli altri morti viventi che vagavano nel campo senza più cibo, poi scivolavano nell’oblio. Indeboliti dalla pressione sanguigna troppo alta, desideravano solo cli rivedere la famiglia prima di morire. L’unico lavoro forzato si riduceva a quello di seppellirsi a vicenda. A volte nessuno sapeva di chi fossero quei cadaveri. I giovani diventavano vecchi in pochi mesi. Le otturazioni dei denti potevano anche fornire più oro di quanto fossero riusciti a estrarne nella vita. Venivano buttati nelle fosse comuni. Più a ovest, non lontano da dove dormii la notte successiva, si trova la località abitata più fredda del mondo. A Ojmjakon è stata registrata una temperatura di -71 gradi centigradi.
Basta un freddo molto meno intenso a scheggiare l’acciaio, a far scoppiare gli pneumatici e a far scaturire scintille da un lance con un colpo d’ascia. Quando il termometro scende così, il vapore del fiato si cristallizza e cade a terra in un tintinnio che viene chiamato « sussurro delle stelle». Tra la gente del posto si dice che nei momenti di freddo estremo le parole stesse gelano e cadono a terra. Poi in primavera riprendono vita e cominciano a parlare, allora all’improvviso l’aria si riempie di pettegolezzi superati, battute mai sentite, pianti cli dolore dimenticati, parole d’amore rinnegate da tempo. Il pianto che potrebbe salire da questa terra non porta riflessione. In un raro passaggio di disperazione, il poeta Mandel’stam, morto sulla strada per Kolyma in un campo di transito vicino a Vladivostok, immaginò che la sordità della Russia si portasse via ogni significato. Non c’era futuro capace di sentire. A dieci passi le nostre parole non hanno suono... Ma le parole ritornarono... Mandel’stan, Shalamov, Ginzburg, Babel’: ritornarono per perseguitare e minare le basi dell’impero di ghiaccio, anche dopo che quelli che le pronunciarono se ne sono andati. Quando la corriera scese verso Magadan, la capitale del dolore, l’alba doveva ancora sorgere.
La città dilagava in una costellazione di luci di fronte al Pacifico invisibile, e mi resi conto con raccapriccio che era bella. Schiacciata tra il mare e le colline, la strada principale scendeva e saliva tra facciate di stucchi dorati e pietra, e poi scompariva verso il porto. Dopo avere trovato un albergo e superato le solite discussioni sul mio visto, uscii incontro a un vento pungente. Tutto era in ordine, o quasi. Le bandiere in piazza Lenin si agitavano sui pennoni e Lenin stesso (che era in piedi con le mani in tasca, senza nulla da offrire) teneva lo sguardo fisso, con luciferina autorità, sul punto in cui gli uffici delle miniere d’oro avevano sostituito il palazzo del Dal’stroj. L’edificio più alto della città — il quartier generale mai entrato in funzione del vecchio partito comunista — era stato lasciato a metà dieci anni prima e occhieggiava alle sue spalle. il vento fischiava tra le aperture. Lungo la strada principale gli uffici e i condomini con i frontoni alti e i colonnati sembravano costruiti per calpestare la terra e i suoi ricordi per sempre, con bandiere e falci e martello in stucco.
Più avanti incombevano gli edifici costruiti dai prigionieri di guerra giapponesi, con le tipiche facciate a intonaco color miele. Tutto il cuore della città era stato costruito da detenuti. C’era ancora il vecchio ufficio postale, e il teatro (trasformato in mercato) dove attrici e ballerine condannate cantavano e ballavano per i loro persecutori. In quegli anni, i prigionieri che resistevano fino alla fine della pena venivano assegnati qui, al limbo di Magadan. Un luogo di strani incontri e di ricordi insopportabili. I sopravvissuti, scrisse la Ginzburg, avevano lo sguardo onnisciente dei serpenti. E la paura non passava. Sapevano che il prossimo terremoto politico poteva farli di nuovo arrestare.
Nessuno si fidava, nessuno si confidava. Era un universo quasi esclusivamente maschile. La scarsità di donne rendeva le mogli infedeli, dicevano gli uomini, e attirava le prostitute. « La Kolyma è una terra dove il sole non scalda, i fiori non profumano e le donne non hanno cuore». Nel 1980 Magadan era ancora la capitale russa del divorzio. Ormai la popolazione era ridotta a meno di centocinquantamila abitanti, ed era ancora in calo. Molti erano venuti a lavorare qui temporaneamente per guadagnarsi il « rublo lungo » dei salari riservati alla Siberia orientale, ma ora stavano tutti tornando a casa. Le miniere e l’industria ittica erano in declino. li freddo era insopportabile e non c’era in giro quasi nessuno. Il vento spazzava la neve dalle colline. Seguii la via dei Trasporti che aveva visto salire dal porto le colonne dei detenuti. Era tristemente anonima.
Qualche residente ripuliva dalla neve la soglia di casa. I cani randagi razzolavano tra i rifiuti. A nord, lunghe pareti rocciose schiacciavano la periferia della città, e al di là fumavano le ciminiere delle fabbriche, come se dietro le colline stesse passando una nave a vapore. Sotto di me, i monti e i promontori della baia formavano attorno al mare una palizzata circolare incappucciata di neve. L’acqua era blu ardesia e così calma e immobile che conservava la scia di una nave scomparsa. Stavo scendendo la strada che i prigionieri avevano tracciato attorno al promontorio del porto. In cima, da una manciata di casupole, si sviluppava una scalinata dissestata. Era puntellata con lastre di cemento e tutta buche. Era deserta, ma con la mente li vidi venire avanti marciando. Tuffai la mano nell’acqua, oltre il bordo ghiacciato. Provai una strana, fugace esaltazione.
Tutto quello che era successo sembrava passato da tempo immemorabile. Non poteva più (davvero?) ripetersi. La riva era cosparsa cli ferri e cavi, cemento scheggiato, vecchie funi, pietre grezze. Al largo era ormeggiata qualche nave da carico. Allora la mente si affollò di altre navi: le « navi della morte del mare di Ochotsk », come le chiamava Sacharov, che trasportavano i loro carichi di ottomila, dodicimila schiavi stipati nelle stive. Quando passavano davanti al Giappone, i boccaporti venivano chiusi e le imbarcazioni procedevano a luci spente nella notte. Nel 1939 la nave a vapore Indigirka colò a picco col suo carico intrappolato all’interno. Nel 1933 la Dzurma partì troppo tardi e rimase imprigionata nel pack per nove mesi, durante i quali tutti i dodicimila prigionieri morirono assiderati e metà dell’equipaggio impazzì. Quando le navi raggiungevano il porto, i malati e i morti venivano scaricati insieme sul molo dove mi trovavo.
Evgenija Ginzburg era stata una di loro. Fu raccolta da una dottoressa, che la curò e le salvò la vita, forse perché voleva riparare alle atrocità commesse dal marito che era un poliziotto addetto agli interrogatori. La Ginzburg lo capì. Nella Kolyma, disse, la cosa più difficile da sopportare era il ricordo delle persone amate. Forse perché Fedor era un ebreo russo, era cresciuto ossessionato dai campi di lavoro, il suo appartamento era pieno di riviste politiche e di vecchi samizdat. Gli specchi erano appesi alle pareti con lo spago. La cucina era disseminata di bottiglie vuote di vino moldavo e l’atrio era ingombro di attrezzature da montagna e da speleologia. La barba era lunga e incolta, credo, per Io studio delle persecuzioni, o forse era stato altro a imprimergli in viso quell’espressione malinconica. Fu lui a dirmi che in quella città, il cui tetro passato era stato rimosso con indifferenza, uno dei principali campi di transito era sopravvissuto come caserma della polizia di sicurezza. « L’hanno abbandonata cinque mesi fa. Presto la raderanno al suolo.
Tutto viene raso al suolo, da queste parti. Adesso naturalmente è protetta da un muro di cinta». Mi valutò col suo sguardo dolce. « Ma io so come entrarci». Così tornammo alla via dei Trasporti, nel punto in cui attraversava un ruscello e piegava a nord, verso le miniere. Nel complesso di edifici sprofondati nel silenzio, Fedor aveva trovato un varco in un punto crollato lungo il muro di cinta di cemento e filo spinato. Vi si infilò. Dall’altra parte la neve era intatta. Per un attimo restammo fermi a guardare, infarinati di polvere di cemento. Volevo un po' di tempo per prendere qualche appunto, per non dimenticare. Ero il primo straniero che vedeva quel posto, disse, e sarei stato l’ultimo.
Ma cominciammo a correre, come fossimo ladri. Adesso, quando rivedo gli appunti presi in fretta, con la grafia spigolosa per il freddo, il posto mi ricompare in mente con violenza, come in una sequenza di istantanee. Ricordo la mensa (strisciammo sotto le finestre sbarrate) che i prigionieri avevano dipinto con scene naif in tinte pastello: un sogno di quiete tra i campi. il pavimento aveva ceduto sotto il peso delle travi crollate. Ricordo i dormitori e le stanze dove ai prigionieri (immaginai) venivano consegnati i pastrani di bambagina e le giacche imbottite. Poi ricordo Fedor che mi indica un edificio a tre piani di fronte a noi. Superata la porta che si apriva su una serie di gradini in pietra, tirò fuori dalla sacca due paia di stivali di gomma e due elmetti con le luci in fronte, e ci calammo nel buio fetido.
L’acqua che non era ghiacciata ci arrivava ai ginocchi. Le nostre parole echeggiavano in sussurri che andavano a perdersi lontano. « Questo era l’edificio delle punizioni». Continuammo a procedere nell’acqua lungo i corridoi e più giù lungo un canale fognario. Persi il conto delle porte di ferro affioranti nel fetore, delle grate che si affacciavano sul buio.
Ogni cella sotterranea conteneva ancora due piattaforme di legno sostenute da strutture in ferro su cui potevano dormire una quarantina di prigionieri. Solo nel primo sotterraneo c’erano venti celle del genere. Le pareti erano ricoperte di ghiaccio. Lì i prigionieri, spiegò Fedor (ne aveva conosciuto uno), schiacciavano i corpi dei morti contro il muro per isolarsi dal freddo. Avevano lasciato delle scritte appena accennate, illeggibili, grattando la pietra con i cucchiai. « Ser... olenko... 1952... Pant... » Le nostre luci riuscivano a malapena a illuminarle. In quelle caverne senza speranza, disse, la maggior parte dei detenuti era morta. Il suo amico era sopravvissuto perché era giovane. « Che cosa aveva fatto? » domandai. « Non lo sapeva » rispose Fedor. « Ha perduto la memoria».
Nella Kolyma era facile perdere la memoria, aveva scritto Shalamov. Era più spendibile dei polmoni o delle mani. Di fatto non serviva a nulla. Un’ora prima dell’alba ritorno tra le colline verso l’interno per l’ultima volta. Un giovane geologo, Jurij, dice di conoscere la strada che porta a Butugychag e che il suo furgone a quattro ruote motrici può portarci là. Ma non è posto in cui attardarsi. La popolazione nativa degli evenchi lo chiama « Il posto dove le renne si ammalano » perché i pastori si sono accorti che qualcosa non va in quella zona. il terreno è saturo di uranio radioattivo. Come entriamo nella valle, ci colpisce una cortina di neve accecante. Vortica sulla strada come una nebbia bassa, nascondendo buche e lastre di ghiaccio, mentre il motore tossisce e ruggisce.
Jurij smette di parlare quando i fiocchi si infittiscono. Il fascio del faro antinebbia li inghiotte in un imbuto di luce argentata. Sul fare dell’alba ci fermiamo con grande stridore di freni su un passo, mentre la tempesta ulula e spazza la coltre del monte più sopra, sollevando un turbinio di polvere. Aspettiamo che trapeli la pallida luce del mattino, le. lepri artiche vengono a cercare rifugio vicino alle ruote. Jurij si limita a dire: « Passerà! » Ha una faccia tranquilla e leale. Non sorride mai. I capelli e i baffi biondicci e la pelle giallastra sono tipicamente russi.
Dopo un po’ comincia a scendere lentamente nella valle incontro all’alba, e la neve si assottiglia e cessa. Di fronte a noi si intravedono le montagne, non più arrotondate ma fragili e unidimensionali, come venature di foglie giganti appoggiate sul cielo. Cumuli di scorie si ammucchiano lungo il fiume e di tanto in tanto si vedono spuntare le casupole dei cercatori d’oro, linde, con i muri bianchi e le finestre che occhieggiano. Più sotto, i meandri immobili formano estuari luminescenti sopra la pianura. « Questa regione si sta svuotando. Chi ci lavorava si trasferisce a Magadan ». Jurij ha ancora un posto di lavoro, ma non ha nulla da fare e ha dieci mesi di salari arretrati. Non sa che cosa farà. Ha quasi trent’anni. « E una volta a Magadan, si spostano a occidente».
A un tratto abbandona la strada maestra e imbocca una via laterale che quasi non si vede. Di fronte a noi la neve che ha ripreso a cadere scende a ondate verso le montagne. Dice: « Questo era il posto più terribile, Butugychag. Non c’era nulla di peggio. Venticinquemila prigionieri lavoravano qui nelle miniere: politici e delinquenti insieme. Non sapevano delle radiazioni. Neppure le guardie lo sapevano». La neve arriva già ai mozzi delle ruote e avanziamo a singhiozzo, cozzando e affondando come se lo chàssis fosse elastico. I solchi lasciati dalla Land Rover di un cacciatore che ci ha preceduto si stanno riempiendo di neve. « Se ce l’ha fatta lui, ce la faremo anche noi». A un certo punto la lastra di ghiaccio che ricopre un ruscello cede sotto il nostro peso e affondiamo nell’acqua fino alle portiere, ma riusciamo a trascinarci fuori e a raggiungere la sponda opposta. «A questo servono le macchine! Oh, le strade russe! » Per quindici chilometri avanziamo a tentoni tra mucchi di neve, sui ponticelli in rovina dei minatori, lungo il letto asciutto di un ruscello. Uno stormo di pernici bianche frulla all’improvviso davanti alle ruote, le ali bordate di nero si tuffano tra i cespugli come cacciabombardieri.
Le impronte della Land Rover di cacciatore scompaiono e saliamo fino a una valle dove anche i lanci si diradano. E circondata da montagne che quasi la soffocano, incombono a precipizio, stagliate nel cielo lattiginoso. Amano a mano che saliamo, il terreno diventa scosceso e innaturale. In cima si aprono le svasature nere delle imboccature delle miniere, le linee delle teleferiche vacillano sulla salita innevata e ridiscendono in una successione di patiboli cadenti fino al fondo valle. Sotto le imboccature delle miniere il materiale di scarto è scivolato giù spianando i declivi. E l’aria attorno a noi è cambiata. La neve è come sospesa in una nebbiolina luminescente e riempie la valle di un bagliore spettrale; intanto è sorto un sole velato. Alla nostra destra, dietro una staccionata di filo spinato collassata, una fabbrica di tre piani in rovina si erge con i suoi muri bianchi sopra un fiumiciattolo bianco. Era l’impianto di flottazione per l’uranio, spiega Jurij, è ancora pericoloso entrarci. Una squadra di lavoro poteva morire in pochi mesi. Accelera con decisione e l’edificio scompare alle nostre spalle.
«Anche quelli che sono usciti di qui, sono poi morti per le radiazioni». Dopo circa un chilometro il furgone slitta su per una scarpata che non riesce a passare. Proseguiamo a piedi, nel silenzio limpido e smagliante. In alcuni punti la neve ci arriva al ginocchio. Jurij mi precede, indifferente, col berretto abbassato fin sul collo. Io seguo le sue orme, mi batte il cuore come se stessimo per entrare in una cattedrale, o in un obitorio. Invece raggiungiamo un gruppo di edifici amministrativi in pietra gialla. Sono in rovina, con i tetti sfondati e le porte scardinate e marcescenti. I telai delle finestre sono rettangoli argentati di neve aperti sul nulla. Una serie di gradini conduce a una veranda da cui si apre una porta su un vuoto profondo almeno sei metri. Il poeta Anatolij Zigulin, sopravvissuto a questo campo negli anni Cinquanta, descrisse mutilazioni brutali, incidenti, assassini tra detenuti, scioperi disperati. li prigioniero non aveva nome, non aveva identità. Veniva chiamato con un semplice numero.
Alcuni erano in catene. Dovevano salire per sei chilometri fino alle miniere; c’era una squadra di detenute che doveva trascinarsi ogni giorno per dodici chilometri per portare al campo sull’altro lato della montagna le razioni di cibo gelate. Le strutture in ferro della recinzione si reggono ancora in piedi, in doppia fila tra le torrette crollate. Sotto la neve i piedi inciampano su oggetti che possiamo solo immaginare, e portano alla luce pezzi di filo spinato. Macchinari arrugginiti affiorano in superficie. Più avanti, attraversiamo la zona dei dormitori delle guardie e delle celle di prigionia in rovina. Nelle camerate senza più tetto le panche delle guardie sono ancora al loro posto, con una fila di ganci per i cappotti. La neve si è accumulata in mucchi cristallini sui tavolati dei letti. Un paio di stivali giace abbandonato vicino a una stufa. Da ogni cosa trapela la rozzezza e lo squallore della quotidianità. Porte di ferro scheletriche si aprono su celle d’isolamento di un paio di metri quadri. Si vedono ancora le fenditure da cui venivano fatte passare le razioni per i prigionieri, le finestrelle con le sbarre sono ancora intatte, e così la stufa nella sauna delle guardie. L’aria sembra fina. Ma le guance di Jurij sono rosa e screpolate. Scalcia via la neve da una seria di ceppi conficcati nel terreno, per mettere in evidenza delle fondamenta in legno. « Qui c’erano le tende » dice. « Dormivano qui».
Era così in quasi tutti i campi della Kolyma. I prigionieri vivevano e morivano nelle tende. Per disperazione infilavano muschio isolante e torba tra i due strati di telone, li spruzzavano di segatura bagnata e vi appoggiavano delle assi all’esterno. Dentro c’era un’unica stufetta di ghisa. E adesso la neve scende, soffice e insistente. Cade sopra i picchetti e ricopre gli edifici con pallida indifferenza. Si infila nei buchi dei tetti, invade le camerate delle guardie, i locali dell’amministrazione, dell’indifferenza, della noia.
Riempie la valle di una semitrasparenza insana. Jurij continua a prendere a calci le piattaforme delle tende, poi mi guarda. « Lo sa, mio nonno faceva il postino al villaggio. Ha passato anni in un campo per avere detto una battuta su Stalin». « Una battuta? » « Sì, si occupava del telefono del villaggio, e un giorno ha detto a un conoscente che passava di li: ‘Ehi, c’è Stalin che ti vuole al telefono!’ Così è finito nei campi per cinque anni. I miei genitori devono averne sofferto molto». Schiaccia sotto lo stivale un picchetto di legno. « Noi tutti siamo cresciuti con genitori che non parlavano». Saliamo fino al punto in cui dovrebbe trovarsi il cimitero, ma sotto la neve è introvabile. La luce opalescente è ancora più intensa sopra la valle. Attorno a noi gli alberi e i cespugli sono coperti di neve e appesantiti, come se fossero carichi di frutti bianchi. Fremono in ondeggiamenti impercettibili. Raccolgo da terra qualche ago di cedro nano, i prigionieri li mettevano a bollire nella vana speranza di evitare lo scorbuto.
Dico: « Comunque vada adesso, è sempre meglio di prima». Dapprima Jurij non risponde. Fa tutto con grande lentezza. Ha una lieve balbuzie. Dice: « Quelli erano tempi di religiosità, in un certo senso. La gente credeva a qualcosa». Sembra che li rimpianga. E così i patimenti sono piovuti dal cielo, con la naturalezza della pioggia o della grandine. Non c’era nessuno da accusare. Nessuno che fosse abbastanza vicino, abbastanza concreto. L’impero di Stalin, come il Reich di Hitler, era concepito per durare tutto il tempo immaginabile. Il passato era stato risistemato per sempre, il futuro preordinato.
Dico, non riuscendo a capire: « Ma tutto questo non tornerà più». Jurij mi spiega: « Noi non siamo fatti come voi occidentali. Forse siamo come eravate voi secoli fa. Qui siamo in ritardo con la storia. Da noi il tempo procede in senso circolare».

Non voglio sentire queste cose, non qui, nel cuore della tenebra. Voglio che definisca questo posto un atroce mistero. Voglio che si rifiuti di comprenderlo. Con quei suoi baffi spioventi e gli zigomi tartari, lo considero la quintessenza del carattere russo, la cartina di tornasole per il futuro. L’aria di montagna mi sta dando alla testa. Ma la sua mano che stava tracciando un cerchio nell’aria, si solleva, esitante. « Forse procede a spirale » precisa, « sale lentamente». Guarda lontano, dove le teleferiche pencolano in una processione spettrale sopra le colline. «Vorrei che mio nonno fosse ancora vivo. Gli piaceva scherzare. Adesso si può scherzare su tutto. Questo ci è rimasto. Le battute». Gli passo un braccio sulla spalla, ma siamo troppo grossi nei giacconi imbottiti e la mia mano scivola via. Per la prima volta sorride, schiude le labbra sui denti ingialliti, poi ritorniamo al sentiero. E sulla discesa gelata si mette a cantare.










