Alcune pagine dello splendido libro "In Siberia" dello scrittore di viaggi Colin Thubron che raccontano la realtà e il passato del "pianeta" Kolyma.
[In viaggio da Jakutsk verso Magadan e la Kolyma] Gli unici altri passeggeri sul mio bimotore Antonov erano tre soldati intabarrati nei cappotti e coi berretti calcati sulle orecchie per proteggersi dal freddo. Sotto di noi scorreva la Lena, gelata da riva a riva, con ancora qualche rivoletto grigio acciaio che serpeggiava tra il ghiaccio.
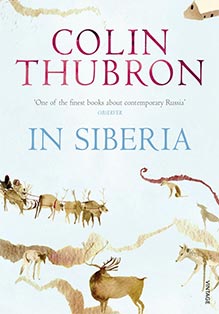
Ma tutti gli affluenti erano compatti e i banchi di ghiaccio trascinati dalle correnti si erano arenati sugli isolotti coperti di neve. Avevo sperato di trovare un camion diretto a est, verso Magadan e il Pacifico, ma l’unica strada era inagibile, crepata dal permafrost, e l’Antonov malconcio era stato l’unico mezzo disponibile. Quando decollò sopra Jakutsk, la città mi apparve un collage disarticolato di migliaia e migliaia di casette sprofondate nella neve, con i muri che sembravano tratteggi a matita e i sentieri scuri intorno. Mi parve di intravedere lo spazio vuoto del circo di Marfa e Sergej, poi riconobbi la statua miniaturizzata di Lenin nella piazza, infine la scacchiera dei condomini dove Tanja aspettava il futuro e dove Mochanov si arrovellava sull’origine dell’uomo. Alla fine le nuvole coprirono tutto e puntammo a est, sotto un cielo sempre più scuro.
Le vibrazioni leggere e continue dell’aereo mi tennero sveglio, in un vago stato di allerta. Di tanto in tanto, quando le nuvole si squarciavano, un deserto ghiacciato di monti baluginava sotto di noi, senza segni di vita. Una desolazione selvaggia che andò avanti per mille chilometri. Settecento anni prima, lungo l’unico sentiero tracciato, uno sparuto gruppo di commercianti di Jakutsk portava alle tribù impoverite mattonelle di tè e vodka di contrabbando, per ritornarne con avorio di mammut, pellicce e qualche ragazza destinata ai bordelli di Jakutsk, venduta dai clan al prezzo di una misera renna. Adesso sotto di noi le valli erano annerite da lanci stentati, e i fiumi giacevano inerti. Poco dopo sorvolammo un ghiacciaio vergine punteggiato di picchi e burroni. La sua glaciale immobilità riempì la cabina. I soldati dormivano imbacuccati e io guardavo giù, inebetito. Nella memoria dell’uomo contemporaneo, quella vastità era solo un continente di campi di sterminio.
Nel 1931, qualche anno dopo la scoperta di immensi giacimenti auriferi, una regione che abbracciava tutta la Siberia nordorientale oltre il fiume Lena — un territorio più vasto del Messico — fu messa sotto il controllo di un’agenzia che si chiamava Dal’stroj e che divenne ben presto una branca del ministero degli Interni e della polizia. Dal’stroj era una legge a parte. Sotto la sua giurisdizione la costituzione sovietica non entrava in vigore. Governò un incubo a occhi aperti. Questa terra della Kolyma ricevette in dono ogni anno decine di migliaia di prigionieri arrivati via mare, la gran parte innocente. Nel punto in cui sbarcarono costruirono il porto, poi la città di Magadan, poi la strada verso l’interno fino alle miniere, dove morirono.
All’inizio i detenuti erano kulaki e criminali comuni, poi — quando la paranoia di Stalin dilagò — presunti sabotatori e controrivoluzionari di ogni classe: funzionari di partito, soldati, scienziati, medici, insegnanti, artisti. Perirono nelle gallerie delle miniere, uccisi dai crolli o dai carichi, dai fumi di ammonio e dalla silicosi, dallo scorbuto e dalla pressione del sangue troppo alta, sputando sangue e tessuti polmonari. In inverno, quando le caldaie a vapore fondevano la sabbia aurifera, trascinavano le scorie dai capanni per il trattamento di separazione all’esterno, dove la temperatura scendeva sotto i quaranta gradi, ed entro un mese morivano di polmonite o di meningite.
Dopo meno di dieci anni la Kolyma arrivò a fornire un terzo della produzione mondiale di oro. Ogni chilo,è stato calcolato, costò una vita umana. Ma il numero dei morti rimane di fatto sconosciuto. Si è ipotizzata una cifra oltre i due milioni. Era già notte quando atterrammo a ottanta chilometri dal Pacifico, a Sokol [Sokol-Magadan nella Kolyma], dove dormii in una pensione vuota. Due corriere a lunga percorrenza, mi dissero, viaggiavano ancora all’interno quando le nevicate non erano troppo forti, e fu con una di quelle — e con un po’ di autostop — che mi inoltrai fino alle colline della Kolyma.
Avevano la monotonia dell’eternità. Contornavano la strada come echi o riflessi di se stesse, arrotondate come antichi tumuli. In qualche caso il vento aveva eroso le cime riducendole a pelate di roccia marrone. Sembrava un territorio informe, trascinato in qualche altra era geologica. E illuminato solo per metà: il sole infatti saliva percorrendo un quarto del cielo ma poi subito ridiscendeva. La strada che percorsi superando villaggi silenziosi collegava un tempo Magadan con un arcipelago di campi auriferi, lungo un tratto di cinquecento chilometri. Ancora oggi viene chiamata la «Strada delle Ossa». All’inizio furono migliaia i prigionieri impiegati nella sua costruzione, ma era sempre invasa dal fango e il gelo distruggeva il lavoro fatto. Ci vollero ottantamila travi di legno per il consolidamento di un solo chilometro. L’arrivo delle prime nevicate nel 1932 colse i detenuti ancora alloggiati nelle tende e in capanne improvvisate con sterpaglie. Fu uno degli inverni più crudeli a memoria d’uomo. Le tormente di neve infuriarono senza sosta per settimane. Interi accampamenti perirono sotto il gelo: prigionieri, guardie, persino i cani. Di migliaia di lavoratori, solo uno su cento fece ritorno a Magadan la primavera successiva. I primi dirigenti del Dal’stroj furono fucilati come spie nel 1937. Da allora si instaurò un regime di pura crudeltà. Gli indumenti di pelliccia e gli stivali dei prigionieri vennero sostituiti con calzature di tela e giacche imbottite, che si ridussero ben presto a brandelli.
L’intenzione era quella di uccidere. Si passò a una dieta da fame: ottocento grammi di pane, con l’aggiunta saltuaria di qualche pezzetto di pesce salato o di cavolo in salamoia. I deportati si ridussero a mangiare le carcasse degli animali, i licheni buoni per le renne, il grasso delle carriole. La giornata lavorativa raggiunse le quattordici ore, le condanne da scontare i venticinque anni. Si promisero riduzioni di pena a chi avesse raggiunto quote di produzione in realtà irraggiungibili. Le squadre lavoravano freneticamente, ma i corpi logorati dalla fame non reggevano lo sforzo. Se la capacità produttiva si riduceva, per punizione venivano ridotte le razioni alimentati, e la squadra entrava in una spirale di declino fatale. Ogni sera e ogni mattina gli ufficiali, levando la brina dai fogli che tenevano in mano, leggevano elenchi dei condannati a morte e di quelli già giustiziati, e dopo il discorso la banda musicale dei detenuti suonava una piccola fanfara. In tre settimane le miniere rovinavano la salute di un uomo, e in pochi mesi lo uccidevano. A volte intere squadre venivano prelevate sul lavoro e fucilate all’istante. I criminali comuni venivano scelti come sorveglianti e armati di bastoni, e potevano assassinare i detenuti politici impunemente. (il sistema di eliminazione consueto consisteva nel sollevare un uomo e buttarlo a terra fino a che le ossa, già decalcificate, si spezzavano). La maggior parte, però, scivolava nella morte senza che la cosa fosse neppure notata.
Alcuni dei comandanti facevano quel lavoro con gusto, arrivando a scaricare le pistole sui lavoratori schierati durante la rassegna con grida di giubilo. In alcuni campi non ci fu neanche un superstite. In posti così si perdono i propri occhi, e si comincia a vedere attraverso quelli di chi li è morto. Non si ha diritto a quel luogo. E un luogo che appartiene a loro. Ci sarà anche qualcosa di bello? Non si sa. Si vedono solo cartelli stradali che indicano località atroci: Sturmovoj, Urchan, Ojmjakon. I campi lungo la strada sono stati saccheggiati del poco materiale utilizzabile. Solo qualche baracca viene riutilizzata come deposito, altre sono ridotte in macerie, circondate da qualche superstite picchetto di cemento. Le torrette di sorveglianza sono crollate. Tumuli e trincee si confondono sotto la neve e tra gli sterpi incolori. Nella notte la corriera raggiunge gli edifici illuminati a giorno di Orotukuan: sessanta anni prima era un centro per interrogatori interminabili, disseminato dei cadaveri di chi aveva dovuto attendere troppo a lungo. Adesso una ragazza vende succhi di frutta da un chiosco senza luce. A sessanta chilometri da li, una valle laterale conduce a Elgen, il campo femminile dove Evgenija Ginzburg [si veda anche Il trasferimento in mare per Kolyma], accolta da un’orda di automi dalle facce paonazze, entrò piangendo all’idea di quello che sarebbe diventata. Perfino i sorveglianti disdegnavano di stuprare quelle donne. A Jagodnoe incappai in un gioviale quartetto di mafiosi che mi portò in giro per la città su una jeep Nissan. « Inglese? Veramente? Come mai qui? Qui è una merda. E venuto per affari? E allora perché, perché? »









